di Gaetano Esposito
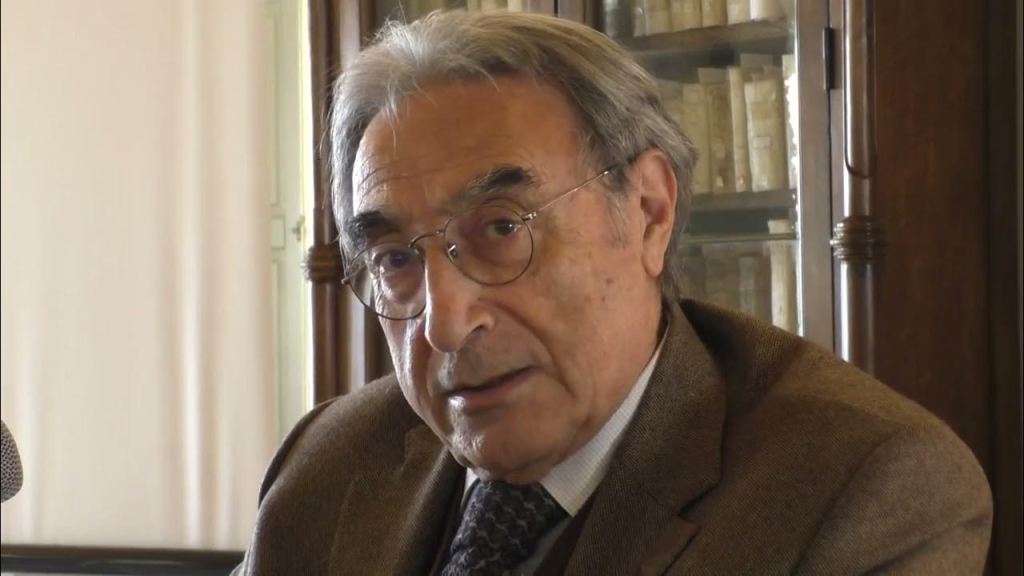
Il primo grande merito che ascrivo al saggio del professore Zecchino è quello di avermi fatto rileggere, con maggior attenzione e consapevolezza, gli ultimi scritti del nostro più grande filosofo. Sono scritti che, se letti con attenzione, costituiscono un corpus unitario che racchiude una filosofia tragica della storia. Uno sguardo penetrante e cupo sugli eventi di quegli anni che raggiunge il suo vertice nei due celebri scritti: L’anticristo che è in noi e La fine della civiltà.
È un Croce diverso da quello che abbiamo conosciuto nelle grandi opere filosofiche, c’è un cambiamento nella sua filosofia della storia. Ci appare come un vecchio filosofo angosciato, attanagliato da <<una stringente inquietudine di una fine che si prepara>>. La fine della civiltà europea, il tramonto di quella Europa del pensiero e della libertà nella quale il filosofo aveva vissuto e operato.
Sono scritti densi di altissima meditazione.
La guerra aveva riportato l’umanità alla barbarie, tanto più minacciosa in quanto proprio la tecnica, che avrebbe dovuto rappresentare il progresso, aveva invece creato sofisticate armi per un rapido sterminio di massa. Il ritorno della barbarie avvicinava Croce al pensiero tragico di Machiavelli e al Vico dei corsi e ricorsi storici e lo allontanava da Hegel e dalla sua filosofia della storia.
È pericoloso l’esercizio del pensare. I fatti si ribellano alle categorie del sistema, la vita nel suo incessante, irripetibile fluire rompe gli argini del concetto e la storia c’insegna che nessun sistema è mai compiuto. Croce lo scoprì in modo doloroso, in quegli anni difficili. Il filosofo dell’immanenza, <<l’immanentista assoluto>> che fu tentato sulla soglia della trascendenza nella notte più lunga e tragica per l’umanità.

E però il lavorio interiore di quel grande Vegliardo, quell’incessante, notturno interrogarsi e rimettere in discussione categorie e concetti davanti a eventi che mettevano in crisi il suo sistema, rappresentano un esempio luminoso di pensiero, di umiltà e di umanità per tutti i pensatori di oggi e di domani.
Il saggio di Zecchino è importante. L’autore ha saputo sottrarre all’oblio lo scritto crociano dopo la bocciatura, ingrata a mio avviso, di Gennaro Sasso. Zecchino ha compiuto una ricostruzione maniacale, completa del saggio crociano e un’ esegesi che oserei dire definitiva.
Perché non possiamo non dirci “cristiani” è un saggio difficile, ambiguo, enigmatico ma Zecchino ne ricostruisce il senso a partire dal contesto spirituale, storico, politico e persino emotivo in cui quello scritto fu concepito. Il saggio crociano viene sottoposto a una rigorosa disamina comparativa con altri scritti crociani precedenti, coevi e successivi; senza contare l’interpretazione autentica che pure viene riportata. Ogni interpretazione precedente viene analiticamente esaminata e confutata. Il saggio è inoltre calato in un più ampio contesto di pensiero europeo. Pagine interessantissime sono quelle dedicate al raffronto tra Croce e Carl Schmitt, il grande annunciatore della fine dello ius publicum europeum.

Altro merito da ascriversi al saggio di Zecchino è quello di aver affrontato con chiarezza alcune tematiche difficili del pensiero crociano, come il tormentato rapporto tra Croce e la religione, il suo rapporto con la chiesa e con la Democrazia cristiana.
Infine, da storico di rango, Zecchino riesce anche, attraverso Croce, a tessere una suggestiva narrazione della storia di quegli anni così decisivi.
al di là delle possibili interpretazioni, Perché non possiamo non dirci cristiani è certamente un accorato appello di un vecchio filosofo a tutte le forze spirituali e morali a scendere in campo per la libertà, che è religione senza chiese.
Ma se fosse solo questo, il saggio crociano non sarebbe così attuale e l’opera di Zecchino sarebbe opera d’antiquario.
Croce ha posto un problema cruciale per noi figli di questo difficile presente e c’impone di farci delle domande.
Possiamo ancora interrogare il saggio di Croce? E cosa ha da dire ancora a noi?
È una domanda che alla quale Zecchino non si sottrae, sin dalla dedica ai suoi cari <<perché serbino la coscienza dell’essere cristiani>>. È già una presa di posizione.
D’altronde, ogni libro di storia che si rispetti parla sempre del presente anche quando parla del passato. Nell’ultima parte del libro viene esaminata l’attualità del saggio crociano, ed è quella la parte che ritengo fondamentale.
È un problema ancora aperto. Le nostre riflessioni cominciano lì dove il libro finisce.
La crisi che viviamo è assai più profonda di quella che visse l’epoca di Croce.
Le guerre che oggi si combattono nel mondo sono tutte guerre di civiltà e di religione assai più di quella grande guerra, che pure Croce definiva guerra di civiltà e di religione.
Inoltre, c’è il fondamentalismo, ricorda Zecchino; c’è anche il pluralismo, aggiungo io, che ci sfida e ci mette in crisi ogni giorno, nelle piccole e nelle grandi cose.
E noi, di fronte al pluralismo, senza accorgercene, ci difendiamo ancora con le parole di Croce.
Quando si verificò il caso del crocifisso nelle scuole, abbiamo detto che siamo uno stato non confessionale, tuttavia, il cristianesimo rappresenta le nostre radici culturali e pertanto non possiamo non dirci cristiani. Recentemente, un Onorevole ha detto in televisione che non può chiudere le scuole per il ramadam perché noi italiani <<non possiamo non dirci cristiani>>.
Il problema delle radici cristiane dell’Europa è ancora fortemente sentito e attuale; lo stesso Papa Benedetto XVI si è interrogato su questo in un libro dialogo con Marcello Pera dal titolo emblematico: Senza radici.

Davanti a questi problemi le domande che dobbiamo porci sono cruciali.
Possiamo ancora, oggi, difendere le nostre radici cristiane? Possiamo ancora <<lottare per le nostre case e le nostre case>> come voleva Croce? E come? E a quale prezzo?
E ancora: il cristianesimo può ancora svolgere quella funzione salvifica? Funzione che, attenzione, ben si adattava a una visione eurocentrica, perché la fine della civiltà, per Croce e i suoi contemporanei, era la fine dell’Europa.
Oggi siamo passati dal dialogo con altre culture alla convivenza con le altre culture, e la convivenza ha le sue leggi. Questo è un passaggio epocale che ancora stentiamo ad accettare.
Abbiamo un mondo dove vediamo monarchie teocratiche informate a un indottrinamento religioso, e, in altre parti del mondo, assistiamo a tentativi di cancellazione della cultura, rifiuto cieco della storia e delle tradizioni, scetticismo diffuso e indifferenziato.
Se oggi Benedetto Croce fosse ancora tra noi, avrebbe riscritto un saggio come questo? E a chi lo avrebbe indirizzato? Quali sono, oggi, le forze capaci di assumersi la difesa delle radici cristiane dell’Europa?
E allora, siamo sicuri che termini come radici, identità culturale, religiosa et similia, appartengono ancora al lessico del nostro presente o stiamo parlando un linguaggio del passato?
Non sarà certo un filosofo a dare una risposta a queste domande, e nemmeno uno storico. Sarà la Storia, ancora una volta, a dirci in quale direzione noi tutti stiamo andando.
Gaetano Esposito




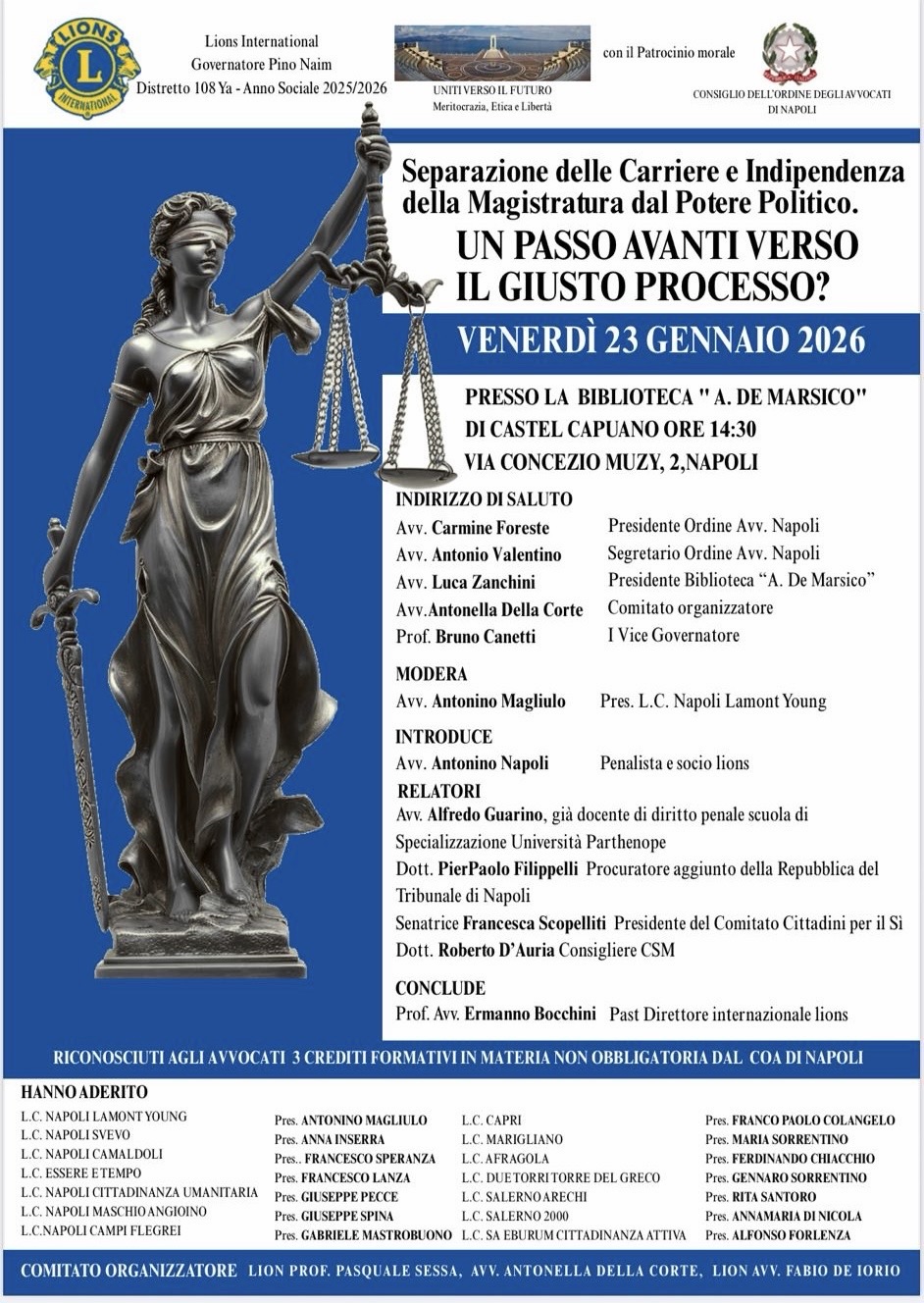

Lascia un commento